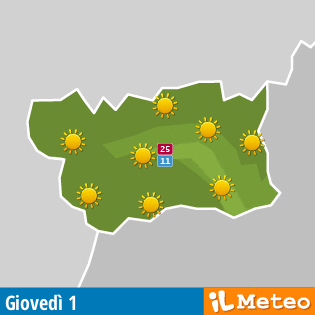In 1200 a Saint-Vincent per il professor Barbero: dai Salassi ai Romani che odiavano le montagne
Sull'attualità politica e i venti di guerra, il professor Barbero: «nei miei incubi ho l’impressione che possa essere così, il riarmo non è segno di sicurezza»
In 1200 a Saint-Vincent per il professor Barbero: dai Salassi ai Romani che odiavano le montagne.
Il professor Alessandro Barbero
La conquista romana della Gallia Cisalpina.
Ripercorrendo i secoli di storia antecedenti la fondazione del capoluogo regionale, in una carrellata storica che ha affondato le radici nella storia delle popolazioni celtiche cisalpine (nord Italia e litorale emiliano-marchigiano, ndr), dai Liguri, agli Insubri e gli altri popoli celtici sino ai Salassi, il professor Alessandro Barbero ha incantato i 1200 presenti alla serata, apripista alle celebrazioni del 2050º compleanno dalla fondazioned i Augusta Praetoria, Aosta.
La stratificazione secolare dei popoli
«Quando incontrarono i popoli della Gallia Cisalpina, i Romani ebbero l’impressione di avere a che fare con dei popoli con una identità etnica e linguistica molto precisa – spiega il professore – noi oggi abbiamo la netta sensazione che queste identità si siano formate molto lentamente.
I popoli si formano, cambiano e si evolvono, dunque le identità non sono mai fisse se le vediamo nel loro complesso.
Studiando i secoli e i millenni delle civiltà umane ci si rende conto di quanto i popoli siano stratificati e, quelli che incontrano i romani durante le loro varie fasi di conquista sono il frutto di questa stratificazione secolare, questo vale anche per i salassi.
Attraverso l’archeologia e la linguistica possiamo capire che inizialmente esisteva una popolazione indo-europea già presente dall’età della pietra, evoluti poi attraverso la scoperta dei metalli, l’età del rame e del bronzo.
I Salassi, élite di guerrieri dell’età del bronzo
«Fra l’età della pietra e l’età del rame, da cui hanno principio secondo le fonti archeologiche le popolazioni che abitavano la Valle d’Aosta, comprendiamo che erano simili a quelle che vivevano nel vallese, al di là del Gran San Bernardo, come possiamo notare nei reperti a Sion, simili a quelli ritrovati nel sito di Saint Martin des Corléans.
Con il tempo queste popolazioni si sono evolute diventando in prevalenza popolazioni di contadini e pastori governate da un élite di guerrieri che impugnavano armi in bronzo, che conoscevano il cavallo e il carro da guerra.
Nel corso dei secoli i Galli, attraversate le Alpi si fondono con questi popoli, fra invasioni che arrivano sino a Roma e, nel ritirarsi, molti si fermano nella pianura padana e nelle valli ad esse collegate, creando così la Gallia Cisalpina».
I Romani odiavano le montagne
«Quando Giulio Cesare e il Senato decidono che ne hanno abbastanza delle scorribande celto-liguri dei cisalpini, annettendo i territori dove ci sono già città romane come Cremona, Piacenza, Milano e Vercelli, questi territori smettono di essere la provincia della Gallia Cisalpina diventando a tutti gli effetti parte del territorio romano, con la conseguenza che le popolazioni che vi vivono diventano cittadini romani e potranno essere tranquillamente arruolati nell’esercito romano – racconta Barbero -.
Questo tipo di ragionamento funziona fintanto che si raggiungono le pendici delle montagne, che notoriamente sappiamo che i Romani odiano».
A queste parole del professore la sala ride sommessamente …
«Non le capiscono e non osano spingercisi dentro, facendo fatica a pensare che possano essere posti interessanti da annettere, in buona sostanza considerano tutta Italia finché il terreno non inizia a salire.
Questo avviene anche quando Giulio Cesare conquista la Gallia lasciando fuori dai suoi calcoli i passi del Grande e Piccolo San Bernardo, del Moncenisio e del Monginevro».
La disputa scientifica sull’orgoglio dei popoli valdostani
«Tra la fine dell’800 sino agli anni ’30 del ‘900 la storia è stata fruttata a fini politici, asserendo con fermezza e rivendicazione di origine, dopo studi archeologici; famosi sono quelli tedeschi nei baltici e nell’Europa dell’Est; che in taluni territori esistevano le radici dei nostri popoli, questo è servito in alcuni momenti storici per legittimare rivendicazioni territoriali basate sulla discendenza comune dei popoli.
In passato questo è stato un tema politicamente scottante, anche se negli ultimi giorni mi hanno fatto notare che è un argomento ancora abbastanza attuale – precisa Barbero.
La nascita di Aosta «Augusta Pretoria è celebrazione ma anche qualcosa di più. Da un lato abbiamo la creazione dal nulla della città in pietra, con i suoi isolati, la sua pianta a scacchiera, il teatro, il circo, le mura e l’Arco trionfale. Dall’altra esiste il problema di chi vivrà in questa nuova città, che verrà abitata dai veterani che hanno contribuito a conquistare quei nuovi territori. Vengono insediati tremila veterani tratti dalle coorti pretoriane, cioè l’élite dell’esercito romano».Barbero approfondisce: « La costruzione di Augusta Pretoria è un grande investimento economico, trattandosi di 64 isolati, contro i 72 di Augusta Taurinorum, Torino, e che, dopo appena quattro anni dalla sua fondazione abbiamo le prove che molti Salassi vengono assorbiti diventando cittadini romani, onorando l’Imperatore Augusto con un lapide in suo onore».
Il lavoro personale del professore
«Quello che sento maggiormente come mio contributo storico e il lavoro più cospicuo che ho realizzato, e sto ancora curando, riprendendo persino in mano dei lavori che avevo cominciato da ragazzino, è senza dubbio lo studio della storia medievale della Valle d’Aosta, la quale è ricchissima di storia, molta della quale magistralmente conservata nell’archivio regionale».
Da dove arrivano le fonti sulla fondazione di Aosta?
«In realtà come per tutta l’epoca romana noi sappiamo molto meno di quanto vorremmo, anzi sappiamo pochissimo. Abbiamo poche righe che ci arrivano dagli storici antichi, poi in aggiunta alle fonti scritte ci vengono in aiuto aggiungendo nozioni, sono loro che studiando le città e il territorio ci aiutano a comprendere un po’ più a fondo il passato, altrimenti saremmo fermi a Tito Livio e Strabone che con poche parole ci dicono Augusto conquistò e fondò questa e quella città».
Il Professore, preferendo non rilasciare interviste riguardanti la stretta attualità parlamentare degli ultimi giorni, riguardo alla bagarre nata dal discorso della Presidente del Consiglio sul manifesto di Ventotene, ha risposto alla domanda di come la storia sembra che rischi di ripetersi riguardo ai venti di guerra che scuotono il mondo.
«Nei miei incubi ho l’impressione che possa essere così, cioè il presente mi sembra sempre di più simile all’Europa appena prima del 1914 e allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando da tutte le parti si parlava di come potesse essere normale l’arrivo di una prossima guerra, premendosi per riarmarsi, credendo che nel riarmo ci fosse la sicurezza, senza rendersi conto che proprio con quei discorsi si andava dritti filati verso la guerra».
La corsa ai biglietti e il successo di Barbero
«Non so il perché di questo mio successo- ha detto il professor Barbero -.
Ho la fortuna di parlare di storia, cioè di una delle cose più facili da rendere appassionanti e da far capire.
Poi vengono ad ascoltare me perché ormai si sono forse abituati a sentirmi parlare ed è una cosa che si alimenta da sola.
La cosa bella di questo successo è il fatto di incontrare persone che mi conoscono quando meno me lo aspetto, come ad esempio essere fermato da una capo treno che mi riconosce e vuole salutarmi».
(emiliano pala)