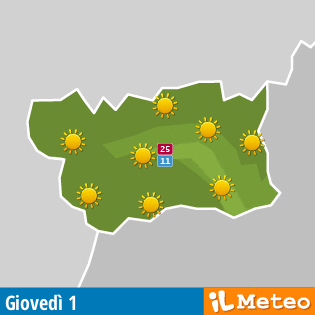Omar Bouamer e Marco Ranfone: quando la corsa è quella per salvare i pazienti
La storia di due runner che di professione fanno gli infermieri, impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus
Omar Bouamer e Marco Ranfone: quando la corsa è quella per salvare i pazienti. La storia di due dei runner più conosciuti di chez-nous. Rivali quando si tratta di gareggiare, ma uniti all’interno dell’ospedale Parini di Aosta per fronteggiare il Coronavirus. Entrambi in prima linea. Omar, nel reparto di rianimazione, Marco nel reparto Covid 3-4.
Le loro storie sono raccontate su Gazzetta Matin.
Omar Bouamer: «La corsa più importante è quella per salvare i pazienti»
«È un momento molto complicato, ma essere sportivo mi aiuta, perché sono abituato a tenere duro nei momenti di difficoltà». Omar Bouamer – ex calciatore dilettante, adesso runner di livello nazionale passato dalla S.Orso al Parco Alpi Apuane – risponde al telefono prima di uscire di casa per il turno di notte. Laureato ad Aosta, dal 2012 è infermiere nella rianimazione del Parini. La stagione agonistica avrebbe dovuto partire in questi giorni, ma il pensiero di Omar è distante mille miglia dalle rinunce sportive.
«Ho smesso di andare a correre dopo l’8 marzo»
«Ho smesso di andare a correre dopo il decreto dell’8 marzo, perché noi sanitari dobbiamo dare l’esempio – spiega -. Negli ultimi giorni ha iniziato ad allenarmi un pochino in casa perché mi aiuta a scaricare e a essere tranquillo. Alle gare non penso, la corsa più importante, in questo momento, è salvare la vita dei nostri pazienti».
«L’ambiente è surreale, l’impatto emotivo molto forte»
Una gara tosta, da disputare in condizioni nuove, sconosciute, complicate.«Con tutti i colleghi ce la stiamo mettendo tutta – aggiunge -. L’ospedale è stato stravolto, i coordinatori e i responsabili stanno facendo grandi sforzi per metterci nelle migliori condizioni di lavorare e a noi i DPI non sono mai mancati. I posti letto in rianimazione sono stati triplicati. Un discorso è vedere la situazione da fuori, un altro è entrare nella terapia intensiva. L’ambiente è surreale, l’impatto emotivo per me è stato molto forte, immagino per i pazienti. Da operatore sanitario, però, sai che il tuo stato d’animo lo devi mettere da parte per riuscire a essere forte e renderti utile. Con i colleghi, i coordinatori, i medici e gli oss cerchiamo di umanizzare le cure, l’approccio al paziente viene curato il più possibile. I medici comunicano la situazione ai parenti e noi infermieri li chiamiamo, se possibile proviamo a farli parlare con i loro cari, se no facciamo comunque sentire loro che siamo presenti e che non sono da soli».
«Non siamo eroi ora, non eravamo fannulloni prima»
Mai come durante questa emergenza è vero che ogni giorno ha la sua pena.
«Ogni turno è dura – ammette Omar -. Il peggio è quando perdi i pazienti. Fai tutto il possibile, i medici sono maestri, anche loro danno il massimo, ma non basta e per il gruppo intero è una sconfitta. Abbiamo perso tante persone, non si può morire così, ma sai che devi continuare perché devi dare il 100% per un altro malato. Sono quasi quattro settimane che lavoriamo con questi pazienti, non abbiamo orari fissi, finisci col mangiare e addormentarti a orari impensabili, ma sai che devi prenderti cura di te. Se vuoi reggere la botta e fare il tuo devi stare bene, solo così puoi essere utile per gli altri. Una volta dentro il tempo si ferma, l’orologio serve solo a scandire i tempi per controllare i pazienti. Il mio è un lavoro bello e difficile, ma lo era anche prima che la collettività scoprisse la nostra importanza. Percepiamo il calore e l’affetto della gente, ci fa piacere, ma non siamo eroi, così come non eravamo fannulloni prima».
«Importante accompagnare il coraggio alla paura»
Inevitabile parlare di paura. «E’ normale che ci sia – dice -. L’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna farsi sopraffare, se no diventa un ostacolo ad andare avanti. Quando ho paura la paragono a quella dei malati che ho di fronte e riesco ad affrontarla, a gestirla. Prendiamo tutte le precauzioni raccomandate da OMS e ISS, facciamo quello che dobbiamo con scienza e coscienza e andiamo ad aiutare queste persone che stanno male».
«Quando tutto sarà finito, farò un bel respiro che porti via la pressione»
Ci sono anche momenti belli.
«Vedere i primi che si risvegliano e riescono a dare il giro è l’attimo che ti dà ancora più forza per andare avanti, lavoriamo per quello – conclude -. Quando torno a casa faccio fatica a staccare dal lavoro. La cosa che mi pesa di più è non vedere genitori e fratelli da tre settimane, ma è giusto tutelarli. Mi manca la quotidianità che di solito vivi senza pensarci. Quando tutto questo finirà farò un bel respiro che porti via tutta la pressione che ho addosso».
Marco Ranfone: «Sentivo la necessità di fare il mio dovere»
«Quando il 18 marzo è finito il progetto Mismi, ho dato la mia disponibilità all’USL e nel giro di una settimana mi è stato fatto il contratto interinale; sapevo che potevo finire nel reparto Covid, ma sentivo la necessità di fare il mio dovere in un momento difficilissimo».
Giusto dodici mesi fa, Marco Ranfone festeggiava la laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche partecipando con la canotta della Cogne a Vivicittà, la classica che apre il calendario podistico. Oggi, invece, è in servizio nel reparto Covid 3-4 del Parini e di mettere un pettorale proprio non se ne parla.
«Essendo lontano dalla pratica clinico-assistenziale dal 2016, quando avevo conseguito la triennale, mi sono trovato in un ambiente e in un gruppo per me nuovi – esordisce -. Sono stato accolto da un team eccezionale, forte, propositivo, coeso, nonostante sia composto da personale di reparti diversi. Tra di noi c’è aiuto reciproco e ho subito percepito grande appoggio dai colleghi che non conoscevo. Il clima tra medici, infermieri e oss è positivo, non si molla».
La zona off limits del reparto Covid
Marco si è trovato a lavorare in una zona off limits.
«Il nostro reparto è completamente isolato, al suo interno tutto può essere contaminato – spiega -. Le singole camere sono sempre chiuse e vanno considerate zone rosse dove la carica virale è maggiore. Dentro abbiamo sempre tutti i dispositivi individuali di protezione. Il turno è di otto ore, con una pausa di mezz’ora a metà nella quale si può uscire operando la svestizione per mangiare e rilassarsi».
«Vestirci e svestirci sono momenti delicati, importante essere in due»
Proprio l’ingresso e l’uscita dal reparto sono momenti delicati. «A vestirci e svestirci impieghiamo dai 5 ai 10 minuti – aggiunge -. Con il passare del tempo si prende la mano e ci si velocizza, ma è importante essere sempre almeno in due, così uno controlla l’altro e verifica che tutto sia a posto. Un momento ancora più delicato è la svestizione, visto che quello che hai addosso, per definizione, è tutto contaminato e ci vuole maggiore attenzione, non bisogna farsi tradire dalla voglia di andare a casa. Da sportivo posso dire che sono i nostri ultimi cento metri, da curare in ogni minimo dettaglio. Le condizioni di lavoro con tutti questi presidi addosso determinano un confort peggiore rispetto al solito, ma lo sforzo che sta facendo l’azienda è alto e i DPI da noi ci sono sempre stati. La fatica maggiore è a livello mentale».
«Il Covid-19 è orribile, toglie anche il lato umano della morte»
Quindi aggiunge. «Non ho paura di infettarmi, mi sento tutelato dai dispositivi, ma ho timore di non riuscire a mantenere alta la soglia di attenzione per tutto il turno. Il bello è che non mi sento, e non sono, mai solo. Far parte di questo meraviglioso gruppo mi dà la forza di alzarmi alle 5.30 del mattino per andare in ospedale. Approcciarsi a questi malati che non hanno la possibilità di vedere i loro parenti è difficile. Noi e i medici proviamo a metterli in contatto, però i pazienti sono inevitabilmente soli. Il Covid-19 è orribile, perché toglie anche il lato umano della morte. Quello è il momento più difficile, ancora più duro da accettare rispetto al solito, perché viene meno la possibilità di concedere ai famigliari l’ultimo saluto. La prima volta è stato impattante, tutto è spersonalizzato».
«In casa abbiamo attuato una separazione domiciliare»
Marco abita con i genitori e la vita in famiglia ne ha risentito.
«Abbiamo attuato una sorta di separazione domiciliare – conclude -. In casa ho una camera e un bagno solo per me; qualche contatto è inevitabile, ma mia mamma si dà ancora più da fare di prima sul fronte delle pulizie domestiche. Non posso fare a meno dell’attività sportiva e, quindi, sfrutto il tapis roulant e i rulli. Sono dipendente dallo sport e, se voglio stare bene, devo allenarmi. E’ molto monotono, ma la situazione richiede queste attenzioni e mi sembra di aver trovato la giusta strategia. Aprile è il periodo delle prime gare, c’è nostalgia, ma in questo momento la priorità è uscire il prima possibile da questa situazione facendo ognuno la sua parte».
(davide pellegrino)